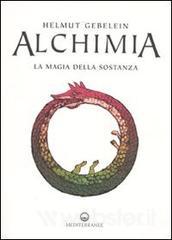di Sebastiano Fusco
Chissà perché, ogni volta che parlo di alchimia, applicandone i concetti a circostanze della cultura contemporanea, c’è sempre qualcuno che se la prende. È vero, si tratta di un’arte in larga misura dimenticata, i cui concetti risultano del tutto impermeabili se considerati esclusivamente alla luce del razionalismo meccanicistico. Tuttavia, è stata (ed è) una delle discipline più a lungo e più pertinacemente praticate da coloro che una volta si definivano “filosofi” (nel senso letterale del termine: amanti del sapere), ed una di quelle su cui sono stati scritti più libri. Jacques Bergier, di professione chimi-fisico con specializzazione nel nucleare, nel Mattino dei maghi affermò che sull’alchimia nei secoli sono stati pubblicati almeno centomila libri. Questo lo disse cinquant’anni fa: oggi, visto che gli alchimisti o sedicenti tali ci sono ancora, e siamo in un’epoca in cui sciaguratamente si scrive e si pubblica con molta maggiore facilità rispetto a un tempo, tale cifra è almeno raddoppiata.
Duecentomila libri inutili
Duecentomila libri sul nulla? Duecentomila libri su divagazioni prive di senso, non utilizzabili per capire alcunché delle circostanze della vita comune? La risposta è sì, se per “vita comune” intendiamo soltanto ciò che appare ai nostri sensi, magari amplificati dagli strumenti d’osservazione, e alle circostanze che ci legano al mondo terreno, e soltanto a quello. Ma se appena ci affacciamo su di una dimensione un po’ diversa (si badi: ho detto “diversa”, non “superiore”) le cose cambiano drasticamente. Questo lo sapevano bene gli antichi (ma chi li legge più, al di là dei sunti scolastici?) e lo sapevano anche i fondatori del pensiero moderno. Galileo era un alchimista, Newton era un alchimista, lo stesso Cartesio lo era a tal punto da doversi difendere dall’accusa di far parte di una setta segreta, come i “Fratelli Rosacroce”. Tutti poveri acchiappanuvole? Ancora una volta, la risposta è sì: costoro, e tanti come loro, erano acchiappanuvole nel senso che la verità la cercavano non sulla terra ma un po’ più su. E non ha importanza se questo “più su” esista davvero, in senso oggettivo: anche se non è tangibile, analizzabile, misurabile, il “più su” è comunque importante, perché il fatto stesso che lo concepiamo gli conferisce esistenza.
Per chiarire, azzardo una metafora. Consideriamo un libro, per esempio un trattato di filosofia teoretica. Il libro è un oggetto concreto: ha un peso, una consistenza, un volume, una struttura complessa fatta di molte pagine, ciascuna diversa dall’altra, legate insieme. Possiamo scrutarlo in tutti i modi, analizzarne densità e peso specifico, valutarne la composizione chimica della carta e degli inchiostri, catalogarne meticolosamente ogni millimetro quadrato valutando le differenze e le omogeneità di ciascuno di essi in rapporto con tutti gli altri: ma alla fine non avremo la minima cognizione di che cosa sia la filosofia teoretica. È così che oggi gli scienziati materialisti stanno studiando il mondo: analizzano il libro come oggetto fisico, ma non si soffermano a pensare che possa avere un contenuto. Anzi, in genere negano che tale contenuto vi sia, e i più estremisti fra loro giudicano blasfemo dal punto di vista del razionalismo anche il solo ipotizzare che sussista un contenuto qualsiasi. Le verità a cui arrivano gli scienziati, nell’ambito della potenza dei loro mezzi d’osservazione: il peso del libro è quello, quella la densità e il peso specifico, quelle le composizioni di carta e inchiostro. Ma lì si ferma la loro ricerca, e non potrà mai approdare ad altro, sempre che questo “altro” ci sia, dubbio che in genere non li sfiora nemmeno, e comunque non interessa loro.
C’è tuttavia qualcuno che vuole andare “più su”, e cerca di capire se, al di là dell’oggetto materiale, vi sia un portato che dia un senso all’oggetto stesso. Non è necessario ipotizzare un senso introdotto deliberatamente da un presunto “Autore” del libro, che non conosciamo, non conosceremo mai e mai sapremo se esista o meno. Ciò che importa è se, in rapporto a noi che cerchiamo d’interpretarlo, questo senso vi sia oppure no. Di conseguenza, il senso, se c’è, non lo cercheremo più nel libro in quanto tale, ma in noi stessi come interpreti del libro. Da questo punto di vista, il senso c’è, eccome: e il fatto che siamo noi a conferirglielo non lo rende meno importante, anzi, ne accresce il valore. L’esperienza c’insegna che è vano cercare un senso nelle cose in se stesse: sono, e basta. Il senso va cercato nei nostri rapporti con le cose, e si tratta in genere di un senso non univoco, ma diverso per ciascuno di noi. Questo lavoro di ricerca non lo fanno gli scienziati materialisti, ovviamente, ma coloro che si occupano dei prodotti intellettuali dell’uomo e del loro modo di manifestarsi e soprattutto d’interagire. Ma non basta ancora. Una volta accertato che c’è un testo da leggere, questo testo va non soltanto letto, ma anche capito. La filosofia teoretica, ammetterete, è una disciplina difficile. Non basta conoscere la lingua in cui è espressa la dottrina, occorre anche seguire il filo di concetti spesso difficili o astrusi, legati a ragionamenti astratti, remoti dal comune sentire e spesso seguenti una logica tutta loro. Tanto più difficile sarà capire il contenuto del libro che abbiamo preso come oggetto centrale della nostra metafora, visto che ciascuno di noi attribuisce un significato diverso alle parole che riesce a distinguere nel testo.
Abbiamo un solo modo per uscire dal labirinto delle infinite interpretazioni: cercare termini sul cui senso vi sia un comune sentire, il cui significato sia accettabile senza discussioni, in quanto evidente di per sé. Evidente, si badi, non alla nostra ragione meccanicistica: quella serve soltanto a misurare il peso specifico del libro. Sibbene, alla nostra sfera emozionale, al nostro sentire profondo, al nostro serbatoio di certezze assolute. In altre parole, dobbiamo cercare dei simboli che ci facciano da guida. Questo non è più compito né degli scienziati né dei filosofi: è precipuo dei poeti. In particolare di quei poeti che anticamente erano definiti vates, in quanto esprimevano una serie di verità parlando giustappunto per simboli.
Tre mondi…
So bene che c’è già chi sta gridando all’irrazionalismo, al tentativo di dare struttura a ragionamenti privi di sussistenza con un procedimento simile alcredo quia absurdum di Tertulliano. Bene, vorrei ricordare che quanto esposto (compresa la metafora del libro) non è che un’applicazione della “teoria dei tre mondi” di Karl Popper. Il grande filosofo della scienza, che mi onoro di aver avuto come collaboratore negli anni in cui dirigevo un mensile intitolatoScienza 2000 (quando, ahimé, il 2000 era ancora molto di là da venire), divideva concettualmente la realtà dal punto di vista umano, in tre mondi: il “Mondo 1” rappresentava la sfera degli oggetti fisici, il “Mondo 2” quella dell’esperienza umana soggettiva e il “Mondo 3” quella dei contenuti oggettivi del pensiero e del linguaggio. Si tratta, guarda caso, della stessa divisione dell’Essere, come concepito dall’uomo, in tre realtà, che era tracciata un tempo dagli alchimisti.
Quando, in alchimia, si parla di un metallo, per esempio il piombo, lo si vede sotto tre aspetti diversi. In primo luogo, c’è il suo aspetto fisico, ovvero quello che è proprio dell’elemento chimico Piombo come lo si trova in natura: pesantezza, colore nero, tossicità, plasmabilità, bassa resistenza al fuoco e così via.
Queste caratteristiche vengono trasferite all’interno dell’uomo e ricercate come componenti della personalità. L’alchimista fa un profondo esame di coscienza per identificare e isolare tutti gli elementi plumbei del suo carattere. È un’operazione in genere lunga e dolorosa, che veniva chiamata scrutinium chymicum (Michael Maier vi ha dedicato uno dei duecentomila libri che nessuno legge più). Occorre grande potere di concentrazione, da conseguirsi con discipline mentali specifiche e grande forza di volontà, perché è difficile portare a nudo compiutamente e sinceramente anche le proprie debolezze più inconfessabili. Si identifica il piombo nel Mondo 1, cioè il macrocosmo, e se ne ricercano le tracce nel microcosmo, ovvero il complesso psicofisico dell’uomo, che del Mondo 1, dal punto di vista alchemico, è una minuscola sintesi.
Successivamente, le caratteristiche plumbee della personalità andavano disciolte usando un solvente apposito o il calore del fuoco. Come il piombo, scaldato, si liquefa, così le concrezioni plumbee della psiche umana erano sottoposte a un’azione destinata a dissolverle. La fase della procedura alchemica era detta solutio, e prevedeva diverse metodiche a seconda del “metallo” coinvolto e della personalità dell’operatore.
Chiave del procedimento è sempre, comunque, l’immaginazione attiva: l’alchimista crea dentro di sé delle immagini (spesso mitologiche: una molto comune era quella di Dioniso fatto a pezzi dai Titani e poi messo a disciogliersi in un calderone) e fa in modo che queste agiscano nella propria coscienza profonda per dissolvere i grumi. Questa procedura segna il passaggio dal Mondo 1 al Mondo 2. L’oggetto in sé si dissolve divenendo in un certo modo il “pensiero dell’oggetto”. Ciò che conta non è più la sua essenza materiale ma la visione che ne abbiamo, la sua identità nella nostra architettura interiore.
La fase successiva è detta sublimatio. Il metallo liquefatto, sottoposto a forte calore, vaporizza. Quella che era sostanza solida diviene gas. Si passa dalla cosa all’essenza della cosa. È il transito dal Mondo 2 al Mondo 3, quello, secondo Popper, dei “contenuti oggettivi del pensiero”. Si può anche dire che si passa dal significatore al significato. Il grumo materiale individuato e disciolto viene sublimato, cioè passa a una fase “aerea”. Se ne coglie il significato recondito, in noi e fuori di noi, e si comprende il senso dei suoi rapporti con noi e con il resto del Tutto (per inciso, le fasi dell’operazione alchemica sono più di tre; ciascuna si suddivide in sotto-fasi, in genere fino a dodici: ma non stiamo facendo un trattato d’alchimia).
Arrivato a questo punto, l’alchimista ha risolto il suo problema principale nell’interpretazione del mondo perché ha riprodotto in sé, nella propria interiorità profonda, l’essenza delle cose: fatto importantissimo perché altrimenti non saprebbe come agire, sulla base del proprio corpo, per giungere ad una realtà superiore (reale o immaginaria, non importa: per lui è reale).
Popper, in un’intervista del 1989 all’Enciclopedia filosofica (è reperibile anche in rete), spiega con molta chiarezza: “Questo libro contiene delle pagine stampate, che rappresentano il Mondo 1. Ma in queste pagine vengono espresse certe idee, che le pagine comunicano in forma comprensibile [il Mondo 2]. È una strana situazione: da una parte ci sono i libri, oggetti stampati, e dall’altra il linguaggio, parlato e stampato. Queste cose hanno in comune le idee che esprimono: c’è dunque qualcosa che può essere tradotto in un’altra lingua e dovrà trattarsi di qualcosa di ‘invariante’. Questa stranissima cosa è ciò che io chiamo il Mondo 3”. Ci sembra abbastanza evidente che il Mondo 3 sia, almeno in parte (la visione di Popper è assai complessa), il mondo dei simboli: il simbolo è infatti l’invariante universale che non muta quale che sia la rappresentazione del fenomeno che vuole spiegare.
… anzi, quattro
Lo schema dei rapporti fra comprensione umana e realtà oggettiva tracciato da Popper non ha relazioni soltanto con l’alchimia. Tanto per citare, nella Kabbalah ebraica è presente la dottrina dei Quattro Mondi in cui è suddiviso il Tutto, visti come quattro fasi della Creazione. Procedendo dal basso, il primo mondo è quello di Assiah, l’universo della materia e dell’azione in cui la Volontà Divina prende sostanza (Mondo 1). Al di sopra c’è Yetzirah, che è il mondo della formazione, in cui si incidono le forme che in Assiah verranno riempite di materia (Mondo 2). Segue Briah, il mondo della progettazione, in cui vengono tracciati i progetti, o le “matrici” delle forme da incidere in Yetzirah(Mondo 3). In più, c’è l’altissimo mondo di Atziluth, in cui sussistono le idee divine che danno luogo a tutta la creazione. Questo mondo pertiene però soltanto a Dio, è inattingibile e inconcepibile, per cui risulta al di fuori della portata di qualsiasi operazione umana. I mondi non debbono essere pensati come successive stratificazioni ma compenetrati gli uni negli altri. Per illustrare il complesso, spesso si ricorre alla metafora del Grande Architetto. Questi è colui che concepisce l’idea di una casa (Atziluth); ne determina lo stile e le dimensioni (Briah); ne disegna il progetto (Yetzirah); raccoglie i materiali e la fa costruire (Assiah). Questa immagine è a dir la verità un po’ approssimativa e deve la sua popolarità al fatto di essere stata adottata dalle varie scuole massoniche, grazie al fascino del mito riguardante l’edificazione del Tempio di Salomone (“mason” è il muratore). A mio personale giudizio, per restare nella metafora del libro, sarebbe più calzante l’immagine del Grande Editore. Questi è Colui che ha l’idea d’un Libro. Chiamiamo questo libro Enciclopedia universaleperché vi è contenuto, letteralmente, Tutto: il concepito e l’inconcepibile, il realizzato, il realizzabile e l’irrealizzabile. Avuta l’idea, incarica uno o più autori di sua fiducia perché scrivano il libro. Consegna il testo ricevuto a una redazione esperta perché lo componga, lo impagini e vi aggiunga illustrazioni e copertina. Dà il tutto a una ipertipografia perché lo stampi, l’allestisca e lo rileghi. Infine, fissa il prezzo. Che, com’è generale costume degli editori (a prescindere della Loro grandezza), risulta alquanto salato: lo sa bene chiunque abbia assaggiato anche un solo spicchio d’esistenza. A questo schema non può sottrarsi chiunque tenti la comprensione di qualsiasi testo che convogli, consapevolmente o no, un frammento della sapienza tradizionale, non essendo possibile prescindere dalla considerazione del polisemismo tipico di questa classe di opere. Non si tratta semplicemente di attribuire significati specifici a strutture simboliche: per esempio, si scrive “soffio” e s’intende “spirito”. Occorre tener presente le stratificazioni complessive di senso che si sovrappongono e s’intessono nella struttura stessa dell’opera.
Ciò vale in particolare per l’ebraismo, che si fonda sulla spiegazione polisemica della Torah, e in genere del complesso delle Scritture. Non voglio addentrarmi in una questione così densa, complessa e così ricca di altissimo senso religioso, che sollecita il massimo rispetto. Voglio soltanto sottolineare come la gran parte dei testi di mistica e di dottrina spirituale tradizionali siano stati scritti tenendo presente la medesima impostazione polisemica, e in base ad essa vadano perciò interpretati. Nel campo della mistica ebraica, poi, la Kabbalah introduce un fattore di complicazione (o di arricchimento, a seconda dei punti di vista) in più. Molti autori si sono dilungati a descrivere il senso delle “stratificazioni” della Torah. Moses de Leon, cui si deve la sistematizzazione di gran parte dello Zohar, identifica quattro strati di senso, precisati (sulla base di una leggenda talmudica, Chaghiga 14b) nella parolaPardes, che significa “giardino” ma alla quale si dà il senso di “Paradiso”.
In ebraico Pardes si scrive con quattro lettere che sono le iniziali di altrettante parole: Pehsat, Remez, Derasha, Sod, ciascuna delle quali convoglia un significato che può tradursi rispettivamente in: semplice, simbolico, religioso, esoterico.
Sono i quattro livelli dei quali è composta la Torah. Il primo, Peshat, è quello letterale: sono le vicende narrative raccontate nel testo, dalle quali si possono ricavare informazioni sulla storia di Israele e insegnamenti di tipo etico e morale, oltre che precetti liturgici e regole di comportamento.
Il secondo livello, espresso dalla parola Remez, utilizza immagini ed episodi presenti nel testo in guisa di simboli per rappresentare qualche altra cosa. Per esempio, in Genesi XVIII Abramo, durante le sue peregrinazioni verso la Terra Promessa, vide davanti alla sua tenda tre uomini. Diede loro acqua per lavarsi e la moglie Sara preparò carne e focacce. I tre viandanti si riposarono, mangiarono e, al momento di andare via, assicurarono che Sara, l’anno successivo, avrebbe avuto un figlio. Sara si mise a ridere, perché era troppo vecchia per avere un bambino. Allora i viandanti risposero dicendo che niente è impossibile a Dio. Qui è presente tutta una serie di simboli. I tre uomini sono tre angeli, carne e focacce sono il nutrimento dell’anima, il riso di Sara è l’anticipazione della gioia per la maternità: il figlio nacque e fu chiamato Isacco, cioè “Sorriso di Dio”.
Il terzo livello, espresso dalla parola Derasha, è quello religioso-omiletico. Espande e commenta ogni verso della Bibbia, in ogni modo possibile, utilizzando soprattutto gli strumenti della ragione e della logica secondo il buon senso rabbinico. Lo scopo è principalmente quello di chiarire gli aspetti etici e legali dei precetti che la Torah prescrive agli ebrei, ma se ne cavano ammaestramenti di cui beneficerebbe l’intera umanità, se li ascoltasse.
Il quarto e ultimo livello, legato alla parola Sod, è quello esoterico dal quale si traggono gli insegnamenti e i precetti per le meditazioni e contemplazioni del mistico. I versetti della Bibbia diventano, a chi sappia leggerli in questo modo, vere e proprie “pietre miliari” che guidano lungo la strada dell’elevazione spirituale. Questo modo di scrittura polisemica non è caratteristico soltanto della Kabbalah o del misticismo ebraico. Di fatto, è presente in tutta la vasta categoria degli scritti fondati sulle dottrine tradizionali, dall’alchimia, all’ermetismo, alla letteratura cortese, alle allegorie d’amore e così via. L’esempio più nobile che mi venga in mente è la Divina Commedia, che lo stesso Dante nell’epistola dedicatoria del Paradiso a Cangrande della Scala definisce “polìsema, cioè di più sensi”. E nel Convivio spiega che i diversi sensi attribuibili alle opere di tal fatta sono il letterale, l’allegorico, il morale e l’anagogico: quest’ultimo “è quando spiritualmente si pone una scrittura la quale per le cose significate significa delle superne cose dell’etternal gloria”. Sono palesemente le stesse categorie di significato racchiuse nel termine ebraico Pardes. L’esempio classico delle quattro interpretazioni èGerusalemme, che in senso letterale è una città nel Medio Oriente, allegoricamente è il simbolo della religione monoteista, moralmente è l’anima che crede, anagogicamente è la “Gerusalemme celeste”, immagine del Regno di Dio. È invitando il lettore a cercare quest’ultimo senso che lo stesso Dante esorta: “O voi ch’avete li ’ntelletti sani / mirate la dottrina che s’asconde / sotto ’l velame de li versi strani” (Inf. IX, 63).
Le nuvole e il fango
A un’operazione del genere non si sottrae la narrativa che si usa definire “popolare”. La circostanza è implicita nello schema dei “tre mondi” divisato da Popper (che del quarto mondo non parla, in quanto i suoi connotati religiosi ne limitano l’accesso ai mistici). Se il Mondo 3 è quello in cui sono ospitati fra l’altro gli “invarianti”, cioè i simboli universali (o se vogliamo archetipici, termine che Popper peraltro si astiene dall’usare), è abbastanza evidente che la via d’accesso più immediata agli enti che lo compongono è la libera immaginazione affabulatrice. Il campo più libero in cui possa esplicarsi tale immaginazione è quello della narrativa fantastica, che non è vincolata da strettoie di tipo storico, d’ambientazione, di connotazione dei personaggi, di verisimiglianza scientifica e al limite neppure dalle categorie della logica. Per questo, è il campo letterario nel quale più densa è la fioritura di simboli carichi di significati su diversi livelli.
Fra i tanti autori di tale narrativa, J. R. R. Tolkien è, con la sua trilogia de Il signore degli anelli, quello dei moderni, che forse più di tutti manifesta una straordinaria densità simbolica. In un mio precedente articolo, intitolato L’uso del simbolo tradizionale in J. R. R. Tolkien (in "Albero di Tolkien", Bompiani 2007), ho cercato di mettere in luce alcune simbologie che riecheggiano dottrine alchemiche. Ve ne sono molte altre. Per esempio, il cavallo che venne dato a Gandalf dal re di Rohan, e che tollerava di essere cavalcato soltanto dal mago, si chiamava Shadowfax (Ombromantonella traduzione italiana) ed aveva il mantello di colore argenteo. Ovviamente, è il simbolo dell’argentovivo, ossia del mercurio. Questo è il simbolo della velocità, dal Dio di cui porta il nome, che è anche simbolo del linguaggio (i maghi lo invocano quando vogliono il dono delle lingue): e Shadowfax, infatti, ha la facoltà di comprendere le lingue degli uomini. Nottetempo, è invisibile; e Mercurio era il Dio dell’invisibilità. Si potrebbe continuare. Un altro esempio è Rivendell, termine dissennatamente tradotto in italiano come Granburrone (non è sciaguratamente l’unico scempio arrecato nella nostra lingua alla densa terminologia tolkieniana). Dell in inglese è l’equivalente della “valletta amena” di dantesca memoria: il luogo delle trasformazioni fecondatrici, in cui acqua e terra si sposano per dar luogo a una nuova vita e conservare il seme delle precedenti. Nome più idoneo non poteva esservi per il posto in cui erano custodite le tradizioni della precedente era del mondo, e in cui si conservavano i frammenti della Spada Spezzata, prossima a risorgere nella sua interezza. Tanto per dare un’idea dell’universalità di questi simboli, nell’alchimia cinese la valle profonda (Rivendell) è simbolo della canalizzazione delle forze che convergono verso il Campo del Cinabro, luogo della nascita dell’Embrione d’Immortalità. Nel sufismo è simbolo del passaggio verso le vette spirituali. Nel Cantico dei Cantici la sposa, simbolo di rigenerazione spirituale, si definisce “giglio delle valli”. Anche in questo caso, si potrebbe continuare all’infinito.
So bene (ascolto già le grida) che Tolkien di tutte queste cose non sapeva niente, e di certo nulla di ciò gli passò per la testa mentre scriveva la sua trilogia. Ma non ha alcuna importanza. Ciò che conta, nel leggere tradizionalmente questi testi, non è quanto l’autore abbia deliberatamente voluto mettervi, ma quanto vi appare. Come già detto, l’accesso privilegiato al Mondo 3 è prerogativa dei poeti. Un tempo, i vates pronunciavano frasi di cui loro stessi non capivano il senso, ma che s’incidevano egualmente nell’animo profondo di coloro cui erano dirette. A questo, si può credere o non credere. Ma negare capacità di suggestione profonda alla vera poesia, cancellarne il potere di sommuovere simboli profondamente infissi dentro di noi, mi sembra dimostrazione di grettezza ferina. Sembra impossibile, ma c’è chi vive immerso in un tale strato di torpore intellettuale. Ho detto all’esordio che in genere, quando parlo del valore perenne dell’alchimia, vengo gratificato di una serie di epiteti che vanno dal credulone al proditorio propalatore di false dottrine. È successo anche per il mio articolo citato, che si è valso critiche basate sull’assunto che l’unico valore del simbolo sia quello di portare significati di livello orizzontale, senza alcuna sollecitazione all’ascesa. Questo equivale a scambiare i simboli con le segnalazioni stradali. Ciò che irrita, in realtà, i portatori di tali concetti è l’idea che possa esservi comunque un’ascesa identificabile dal punto di vista spirituale. Un atto di leso realismo. Delitto grave. Mi confesso colpevole.
Aristofane, nella commedia intitolata "Le Nuvole", divideva anche lui il mondo in tre livelli. Il primo era quello della vita di tutti i giorni. Il secondo era quello del “filosofo”, una parodia di Socrate, che viveva a mezz’aria, in un cesto di vimini tenuto sospeso con delle corde. Il terzo mondo era quello delle nuvole, a cui si affacciava la testa calva del filosofo, che davano responsi. Ancora una volta, sono i tre mondi di Popper. Noi viviamo tutti nel mondo in basso ma con la mediazione della filosofia, ovvero dell’amore per il sapere, possiamo guardare alle nuvole, con buona pace di chi preferisce grufolare nel fango.