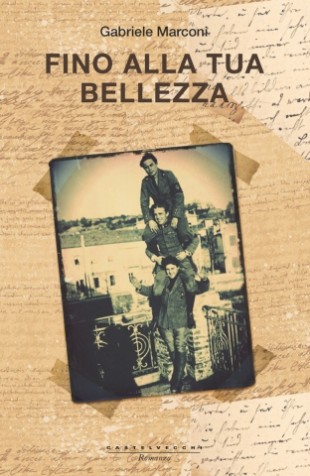..non c’è nessuno che ti costringa a seguire quello che sei, e quello che sei non conta più, perché tanto la vita è solo una lunga attesa della morte, un lungo tentativo inutile di sopravvivenza. Inutile perché il corpo vive, ma le facoltà intellettuali muoiono ogni giorno, schiacciate sotto al peso dei soldi, del lavoro che non hai mai voluto fare, dei politici che non ti rappresentano e degli oggetti che ti fanno sentire ricco, benestante, ma che alla fine ti rendono solo un umile schiavo, che correndo all’impazzata diventa solo un fantoccio delle multinazionali, delle banche, le cui uniche leggi non sono morali ma sono quelle dell’ obsolescenza programmata, della sopraffazione, dell’isolamento, dell’obbedienza e della distruzione.

Fight Club: inizialmente romanzo introspettivo e pungente di Chuck Palahniuk e successivamente ispirazione per il celebre prodotto cinematografico ormai decennale firmato da David Fincher dalla posizione altrettanto critica verso una società eccessivamente fondata sul sistema bancario, consumistico e lontana dalle esigenze delle persone.
Apparentemente risulta illustrazione di un forte disagio individuale, un’invadente esplorazione della coscienza e della psiche di un impiegato, uno come tanti, intrappolato in uno sporco sistema di assicurazioni che calcola il valore della vita umana in dollari, sottostando ad un triste algoritmo comprendente numero di morti in incidenti d’auto, futuri rischi di incidente e relativi guadagni o perdite derivanti dal ritiro dal mercato di automobili mal fabbricate e insicure. L’impiegato, oppresso dal suo lavoro sintomo della malattia che un mercato infetto ha diffuso nella civiltà, soffre di insonnia, e vive in un continuo dormiveglia nemmeno degno di essere chiamato vita perché ‘’con l’insonnia niente è reale. Tutto è lontano. Tutto è una copia di una copia di una copia…’’. Per quante persone la vita è una copia, magari di una brutta copia, di un modello imposto dall’alto e di cui i primi beneficiari non sono certo loro stessi? All’inizio l’uomo cerca di curare il suo ‘male di vivere’ con una sorta di shopping therapy, comprando in maniera quasi maniacale mobili di Ikea, come se la creatività impiegata nel suo appartamento potesse in qualche modo distinguerlo dagli altri. Esamina costantemente il catalogo e compra, compra, compra chiedendosi‘‘Quale tipo di salotto mi caratterizza come persona?’’: ovviamente non funziona. Quello che a tanti può sembrare una sorta di riscatto o di rivincita è in realtà l’ennesima catena che ci stringe: anche un colorato appartamento può diventare una prigione se al di fuori di esso la personalità non si sviluppa e ‘’le cose che possiedi alla fine ti possiedono’’. L’unico modo per uscirne e dormire sonni tranquilli è visitare i gruppi parrocchiali di malati terminali, affetti da malattie di vario genere, e stringerli, abbracciarli, non certo per compassione, bensì per egoismo, e assaporare, oltre al prominente seno di Bob (un massiccio uomo affetto da cancro ai testicoli) il loro dolore, immergersi nella tristezza dell’abbandono. Proprio così, i malati sono emarginati e vivono per l’incontro settimanale con altri malati. L’abbandono dei figli, delle mogli, dei colleghi, i malati sono abbandonati dal mercato del lavoro, dalla società, e nell’oscura saletta parrocchiale sembrano abbandonati dallo stesso spirito vitale che tanto vitale non è. Estraniarsi dal suo dormiveglia e fingersi malato per osservare e vivere del dolore altrui, sì, proprio da osservatore, in una sorta di consolazione all’insegna del ‘‘c’è chi sta peggio di me’’ è la soluzione ideale per l’impiegato. Finché non incontra Marla, che come lui è sana fisicamente, non per questo estranea a una forte spaccatura psichica, e che disturba il suo metodo rinchiudendolo nuovamente nella stretta gabbia dell’insonnia e privandolo del benessere guadagnato dalla sofferenza altrui, rendendolo consapevole che lui non è altro che un impostore, fautore di una folle e falsa messinscena.
Ma non è abbastanza, tanto che l’insonne viene affiancato da un alter ego rivoluzionario, menefreghista, assolutamente anticonformista,impulsivo e pressoché nichilista Tyler Durden, uno che alle regole della società che opprime l’impiegato non ci sta. Lui produce ‘sapone’, vive in una casa abbandonata e viene visto dal protagonista come un alternativa allo schifo di tutti i giorni. Quando ‘misteriosamente’ il colorato appartamento dell’impiegato è luogo di una violenta esplosione inizia la convivenza con Tyler. E’ l’inizio del Fight Club. Il protagonista e Tyler danno vita a una serie di combattimenti clandestini e segreti. Sempre più persone sono coinvolte. L’impiegato capisce di non essere il solo a sentirsi alienato dalla propria esistenza. La violenza funge da antidoto alla monotonia quotidiana, al mancato riscatto della maggior parte degli individui. Potente valvola di sfogo sicuramente, ma per Tyler non è abbastanza. Lui punta a una vera e propria rivoluzione. Ma Tyler non è nient’altro che l’altra faccia dell’impiegato, quella nascosta, arrabbiata, esasperata, a cui non importa più nulla né delle assicurazioni né tantomeno di Ikea. Il Fight Club si trasforma nel ‘progetto Mayhem’ e non si parla più di lotte clandestine, ma di battaglie, combattute dichiarando guerra al sistema, alle banche, ai luoghi di lavoro.
Lo stesso impiegato sottomesso è incarnazione dell’ inetto sveviano e, con il prodotto del suo subconscio Tyler, dichiara guerra alla società che lo ha ridotto un solo corpo, con due anime o forse nessuna. I lottatori si trasformano in esercito, non ci sono regole se non quella di abbattere il sistema. Il sapone diventa esplosivo. Un vortice trascinatore che porta confusione, lutti, altra violenza, vandalismo; una dinamica alla quale difficilmente si riesce a stare dietro, vortice che comincia con una pistola puntata in bocca e si conclude allo stesso modo. L’evoluzione del pensiero di Tyler è coinvolgente, è sicuramente sintomo di rottura con il sistema corrotto che con la sua corruzione miete milioni di vittime, che si identificano con ragazzi, padri di famiglia, medici, professori, artigiani, artisti…tutti quanti.
Isolamento, alienazione, perdizione, esasperazione, rabbia, violenza, oppressione, assicurazioni, banche, malattie, frustrazione, abbandono, caos, estraniamento, collasso: un quadro tutt’altro che ottimista quello della società che Palahniuk propone. Ma sono termini che si trovano solo nel film o nel romanzo? Oppure ci appartengono più di quanto pensiamo? E allora si parla di un racconto frutto della fantasia di uno scrittore pessimista oppure dei risultati a cui una società con i suoi aspetti negativi portati agli estremi può condurre?
E allora si comincia a sentire una voce, simile a quella di Tyler, che ti spinge a voltare le spalle a questo maledetto sistema, a questi sballatissimi criteri di giudizio, a questa infinita e insensata classificazione delle persone in classi sociali, politiche, economiche e quant’altro. Quella voce ti grida che ‘’Tu non sei il tuo lavoro, non sei la quantità di soldi che hai in banca, non sei la macchina che guidi, né il contenuto del tuo portafogli, non sei i tuoi vestiti di marca, sei la canticchiante e danzante merda del mondo!’’ Non contano i sogni, le ambizioni, i meriti, i talenti e tutte quelle cose su cui ruotano polemiche e dibattiti in questo mondo in crisi, dove la crisi più in rilievo è quella economica, non quella di valori, non quella dell’individuo, non quella della mala distribuzione delle risorse; no è la crisi economica quella intorno a cui gira tutto. E quindi si danza e si canticchia nello stesso mondo in cui si è costretti a puntare la pistola alla nuca di un cassiere immigrato e minacciarlo di ucciderlo nel caso in cui non prosegua i suoi studi da veterinario e insegua il suo sogno. Ma a parte Tyler, frutto di una mente collassata, non c’è nessuno che ti costringa a seguire quello che sei, e quello che sei non conta più, perché tanto la vita è solo una lunga attesa della morte, un lungo tentativo inutile di sopravvivenza. Inutile perché il corpo vive, ma le facoltà intellettuali muoiono ogni giorno, schiacciate sotto al peso dei soldi, del lavoro che non hai mai voluto fare, dei politici che non ti rappresentano e degli oggetti che ti fanno sentire ricco, benestante, ma che alla fine ti rendono solo un umile schiavo, che correndo all’impazzata diventa solo un fantoccio delle multinazionali, delle banche, le cui uniche leggi non sono morali ma sono quelle dell’ obsolescenza programmata, della sopraffazione, dell’isolamento, dell’obbedienza e della distruzione.
Distruzione, è proprio questa quella che ottiene Tyler con il Progetto Mayhem (‘Progetto Caos’ nel libro). La distruzione di sé stesso, in un folle dialogo su uno dei piani alti di un grattacielo, tra lui, quello a cui non importa di morire, quello che ‘tanto il sistema si può abbattere’, e l’altra parte, quella che con il sistema ci convive, che in fondo in fondo della ribellione ha paura. E’ l’esplosione delle sedi dei maggiori istituti di credito l’obiettivo di Tyler, e da quel grattacielo ci si può godere lo spettacolo. Il dialogo diventa scontro tra le due facce opposte di un individuo che non ha retto il peso del sistema, individuo che a sua volta viene sopraffatto da sé stesso, talmente la società l’ha indebolito, che si rassegna, e che alla fine, quasi con aria serena, si gode il belvedere dell’implosione dello stesso mondo che l’ha oppresso, della metaforica distruzione dei pilastri della società completamente sbagliata in cui è nato.
Antonino De Stefano (L'Intellettuale Dissidente)