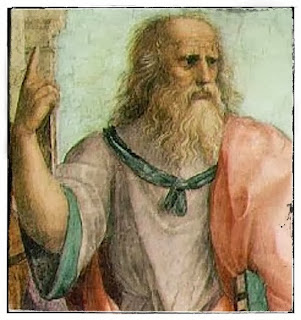da: Barbadillo
Aleksandr Gel’evič Dugin, classe 1962, ha potuto esperire personalmente due transizioni essenziali del secolo scorso: il crollo del blocco sovietico con la conseguente affermazione di un modello geopolitico unipolare di marca statunitense e il passaggio culturale, filosofico ed esistenziale dell’Occidente dalla civiltà moderna alla virtualità del post-moderno.
L’ultimo saggio concepito dall’eclettico intellettuale russo, ad oggi
non disponibile in lingua italiana, si inserisce all’interno di tale
crocevia epocale. The Fourth Political Theory
(Arktos, London 2012) affronta l’ampio spettro di problematiche
suscitate dall’“interregno” in cui l’uomo contemporaneo si trova
scagliato, un simulacro liquido caratterizzato dall’assenza di vincoli
fondativi e dall’alienazione rispetto ad ogni nomos. Jüngerianamente consapevole che “ci
troviamo ad una svolta fra due epoche la cui importanza corrisponde
pressappoco a quella del passaggio dall’età della pietra all’età dei
metalli”, Dugin rivolge una colta, giustificata e serrata critica al paradigma politico-culturale vigente.
 L’intellettuale,
acuto promotore in sede teorica e politica dell’eurasiatismo, trascura
nel presente saggio l’istanza slavofila tipica della proprio
speculazione per volgere uno sguardo più ampio sul mondo occidentale, ed
in particolare sulle sorti di quell’Europa che con la Russia condivide,
pur nella propria precipua autonomia, storia e tradizioni. Il “nemico”
della civiltà eurasiatica viene identificato toutcourt
con il liberalismo, di cui il modello statunitense è il paradigma
immanente; la necessaria critica alle politiche imperialiste promosse
dagli U.S.A. non deve tuttavia distogliere dall’obiettivo polemico
essenziale, insito nella Weltanschauung che è alla base dei diversi epifenomeni della degenerazione e che porta un nome unitario, quello di liberalismo appunto.
L’intellettuale,
acuto promotore in sede teorica e politica dell’eurasiatismo, trascura
nel presente saggio l’istanza slavofila tipica della proprio
speculazione per volgere uno sguardo più ampio sul mondo occidentale, ed
in particolare sulle sorti di quell’Europa che con la Russia condivide,
pur nella propria precipua autonomia, storia e tradizioni. Il “nemico”
della civiltà eurasiatica viene identificato toutcourt
con il liberalismo, di cui il modello statunitense è il paradigma
immanente; la necessaria critica alle politiche imperialiste promosse
dagli U.S.A. non deve tuttavia distogliere dall’obiettivo polemico
essenziale, insito nella Weltanschauung che è alla base dei diversi epifenomeni della degenerazione e che porta un nome unitario, quello di liberalismo appunto.
La pars destruens
operata da Dugin occupa una sezione importante del saggio e si sviluppa
su piani eterogenei: analisi geopolitica, critica filosofica,
prospettiva religiosa e teoria politica concorrono alla decostruzione
degli idoli su cui si regge il mito moderno del liberalismo. A tale
sezione va l’indubbio merito di unire sapientemente ambiti di
riflessione fra loro distinti all’interno di un atanor
alchemico in cui ogni componente si amalgama con l’altro suggerendo una
processualità di significato strutturata su piani diversi ma fra loro
collegati.
I
“compagni di viaggio” di Dugin sono numerosi: Heidegger, Evola, Guénon,
Niekisch, Spengler, Schmitt, Leo Strauss, de Benoist, Husserl, Bateson
sono solo alcuni dei numerosi intellettuali citati dal filosofo russo e
impiegati nella demolizione dei dogmi fondativi della modernità. La
critica al liberalismo non riserva tuttavia al lettore smaliziato
intuizioni sorprendenti: Dugin si limita a rielaborare sinteticamente, e
talvolta con un certo riduzionismo, delle riflessioni maturate
all’interno della cosidetta “letteratura della crisi” e presso gli
aderenti alla Rivoluzione Conservatrice. La sintonia con il più volte
citato de Benoist è in quest’ambito quasi totale: con il filosofo
francese condivide la volontà di oltrepassare l’ormai sterile dicotomia
Destra/Sinistra e sostiene parallelamente un’istanza di superamento
critico dei modelli politici novecenteschi di comunismo e fascismo,
divenuti utili al Sistema stesso in quanto miti incapacitanti e capri
espiatori esecaribili alla luce della moderna religione dei diritti
umani. Dugin contemporaneamente rifiuta la demonizzazione dei
radicalismi politici e teorizza il riassorbimento sintetico di queste
categorie in un nuovo paradigma che sia “e di destra e di sinistra”.
Quanti hanno attaccato il pensatore tacciandolo di intellettualismo e di
ingenerosità nei confronti di una “terza via” già esistente hanno
mostrato di non aver compreso lo sforzo duginiano – sul cui successo è
invece ampiamente legittimo dibattere – di suscitare nuovi mitologemi
adatti a mobilitare l’uomo contemporaneo, nella certezza tipicamente
perennialista secondo cui principi trascendenti ed eterni mutano la
propria configurazione fenomenica in relazione alla struttura immanente
in cui si rivelano.
La
parte decisamente più rilevante del saggio duginiano è dunque
ravvisabile nelle suggestioni costruttive e costituenti indicate
dall’autore. E questo non perché si tratti di soluzioni definitive, ben
strutturate e pragmaticamente attuabili. La teorizzazione di Dugin
risulta al contrario in molti tratti stretta in un baratro fra
un’aspirazione pragmatica e realista, che lo porta a indicare un fronte
politico e internazionale a suo dire disponibile a fronteggiare il
“pensiero unico”, e una tensione teoretica intimamente astratta,
ispirata da speculazioni filosofiche e tradizioni esoteriche di natura
elitaria. É tuttavia in questo tentativo di delineare i contorni di un
paradigma alternativo possibile che si coglie la portata del testo, un
“segnavia” in un percorso utopico sì, ma non utopistico, che
nell’atteggiamento heideggeriano di cura verso il mondo e di
preparazione dell’avvento dell’essere si apra alla natura metamorfica
del reale e ne prepari l’Ereignis.
“Forse solo un dio ci può salvare”, ma all’uomo spetta secondo Dugin
una forte responsabilità esistenziale ed etica rispetto a tale epifania.
L’impegno dell’intellettuale sta allora nella configurazione di
nuovi orizzonti politico/filosofici, nella convinzione che la dignità
della persona, il senso di appartenenza, l’identità della comunità e la
realizzazione spirituale non siano un punto di partenza, bensì un
posizionamento da assumere e un obiettivo da conquistare. Il
saggio di Dugin si pone allora non come l’enunciazione dogmatica e
strutturata di un nuovo modello politico, bensì come un cantiere aperto
di riflessioni finalizzate a contribuire all’edificazione
nell’immaginario collettivo di una Quarta Teoria Politica in cui la
molteplicità e la pluralità siano principi fondamentali. In consonanza
con la dottrina tradizionale dell’Impero, Dugin prospetta una visione di
macro-aree politiche unite da un comune sostrato culturale, storico e
spirituale ma aperte ad autonomie locali e salde nella difesa delle
differenze.
Se
comunismo, fascismo e liberalismo devono essere abbandonati, tutte
queste teorie offrono elementi che, riassorbiti in un nuovo circolo
ermenutico, vale a dire in un differente contesto immaginale, possono
contribuire alla costruzione della Quarta Teoria Politica. Così le
suggestioni positive dei modelli novecenteschi – rispettivamente l’acuta
identificazione delle contraddizioni del capitalismo e il mito
escatologico, la tutela dell’ethnos e della comunità, il valore della libertà umana
(da non concepirsi più individualisticamente ma in senso
personalistico) – possono contribuire alla delineazione di un nuovo
archetipo di autenticità, in cui reificazione, obiettivismo, pensiero
unico, fine della storia e progressismo forzato vengano sostituiti da
una nuova visione del mondo.
Soggetto
di tale paradigma non sarà più il proletariato, né lo Stato etico
fascista o la razza ariana, né infine l’individuo atomizzato ed
edonista, bensì il Dasein,
l’esser-ci. Il ricorso di Dugin al concetto filosofico heideggeriano
pone numerose questioni. É inevitabile domandarsi quale forza
mobilitante possa rivestire una così astratta speculazione teoretica,
partorita da un intellettuale in un’opera di ontologia quale Sein und Zeit.
Il problema rimane, anche perché Dugin non definisce mai in modo
preciso tale termine, lasciandolo sullo sfondo quale mito originario
della propria costruzione. Si possono tuttavia cogliere diversi
riferimenti grazie a cui mi pare corretto indicare nella figura del Dasein una nuova tipologia antropologica – o sovra-antropologica –, frutto di una metanoia
radicale, grazie a cui il soggetto venga reintegrato nelle proprie
possibilità originarie, secondo una visione affine alla tesi
tradizionale della molteplicità degli stati dell’essere. Il Dasein è allora l’uomo autentico, aperto all’essere e dunque al Sacro, sensibile alla Presenza e pro-iettato verso il futuro. Il Dasein
è inoltre un espediente per superare il dualismo razionalista che la
civiltà occidentale logocentrica ha elaborato con successo fino a
condurlo alle sue estreme conseguenze teoriche con uno svuotamento di
significato. Soggetto e oggetto vengono riassorbiti nel Dasein, che è anche inzwischen (frattanto), quanto cioè si colloca nel mezzo sotto un profilo temporale.
Dugin presenta quindi la Quarta Teoria Politica come atto di contemplazione,
rituale teurgico e operazione magica finalizzata a condurre in una
dimensione “sovra-naturale (…) dove non vi è alcuna barriera fra idea e
realizzazione” (p. 181). In questa prospettiva si rivelano nuove
modalità di rapportarsi al mondo: la visione progressiva, lineare e
“monotonica” del tempo e della civiltà occidentale può essere
abbandonata a favore di una interpretazione aperta del flusso
dell’esistenza, definito da Dugin in termini nietzscheani come
compenetrarsi del flusso amorfo dionisiaco e della individuazione
plastica apollinea. La temporalità diventa inoltre reversibile.
Non
solo la concezione del tempo muta, ma anche quella dello spazio, a
dimostrazione di come tali categorie non siano apriori in senso
kantiano, bensì modalità di esperire il reale culturalmente determinate.
Così la topografia politica della globalizzazione, che nella sua
inclusività annulla le distinzioni fra destra e sinistra per sussumerle
al proprio interno, può essere scardinata da un nuovo binomio
concettuale: quello fra centro e periferia. É da quest’ultima
prospettiva che possono partire gli attacchi al modello onnipervasivo.
Al concetto di Dasein Dugin lega quello di Radical Subject,
una dimensione ancor più profonda, a suo dire, della soggettività
trascendentale husserliana, che “mostra se stesso solo nel momento della
catastrofe storica finale, nella traumatica esperienza del “corto
circuito”” (p. 168). Si tratta di una formazione dalle forti tinte
mistiche, non dissimile, in base i pochi riferimenti indicati,
all’Individuo Assoluto teorizzato da Julius Evola. Afferma infatti Dugin
che “il Soggetto Radicale è incompatibile con ogni tipo di tempo. Esso
richiede energicamente l’anti-tempo, fondato sull’elevato fuoco
dell’eternità transigurato in luce radicale” (Ibidem). Siamo di fronte al soggetto integralmente libero, non implicato nel paradosso del postmodernismo libertario che “sotto l’egida dell’assoluta libertà inizia a rimuovere la libertà di dire “no” alla libertà stessa” (p. 85).
Per
Dugin la postmodernità conduce al parossismo le tendenze peculiari
della modernità in una disgregazione totale del senso e in una piena
destrutturazione del reale, su cui il liberalismo moderno ancora poteva
fondarsi. La lezione di Baudrillard, Debord, Deleuze e Guattari è
ben nota a Dugin, che affronta il pensiero postmoderno con un
atteggiamento per certi versi simile a quello tenuto nei confronti della
modernità dai nichilisti attivi e dagli esponenti della Rivoluzione
Conservatrice. É la medesima prospettiva assunta da Heidegger
quando afferma la necessità di una accelerazione del nichilismo: se
davvero si intende superare l’avvento della signoria del Nulla è del
tutto inutile produrre nuovi idoli o attestarsi su posizioni meramente
conservatrici, giacché solo mediante il compimento
destinale del nichilismo si potranno aprire squarci salvifici nel
panorama a tinte fosche che si profila all’orizzonte. Così per Dugin la
postmodernità è inserita inevitabilmente in un ciclo storico dalla
metamorfosi necessaria e inevitabile. La decadenza connessa alla
contemporaneità è sintomo della conclusione di un ciclo e pone l’uomo di
fronte a un bivio: uniformarsi alle tendenze disgregatrici o,
viceversa, cavalcarle e sfruttare l’energia in esse latente. Così Dugin
dimostra un’accurata conoscenza del pensiero postmoderno e si serve
persino di alcune intuizioni sorte in tale fermento culturale al fine di
disintegrare completamente le certezze della modernità liberale e
condurre l’uomo alla soglia del caos, di quel precategoriale originario
che è fonte perenne della totalità manifesta e precede, secondo Dugin,
la visione cristallizzata dell’Essere propria della metafisica
logocentrica occidentale. Il caos “include in se stesso tutto ciò che è,
ma allo stesso tempo tutto ciò che non è. Quindi il caos che include
tutto include anche ciò che non è inclusivo (…) quindi il caos non
percepisce il logos come Altro, bensì come se stesso” (p. 209). É da questa metafisica del caos che potrà risorgere il logos,
che “richiede un salvatore, non può salvarsi da sé. Necessita di
qualcosa di opposto a se stesso per essere ripristinato nella situazione
critica della postmodernità” (p. 210). Dugin tenta così di
innestare nell’arido e spoglio suolo d’Europa un seme rinnovatore,
partorito dalla Tradizione in una delle sue forme metamorfiche.
Consapevoli che la profezia non è scienza, bensì dono di pochi, non
resta che attendere vigili la morte della fenice della nostra Zivilisation in un’attesa accorta e nella costruzione responsabile della sua rinascita come Kultur.