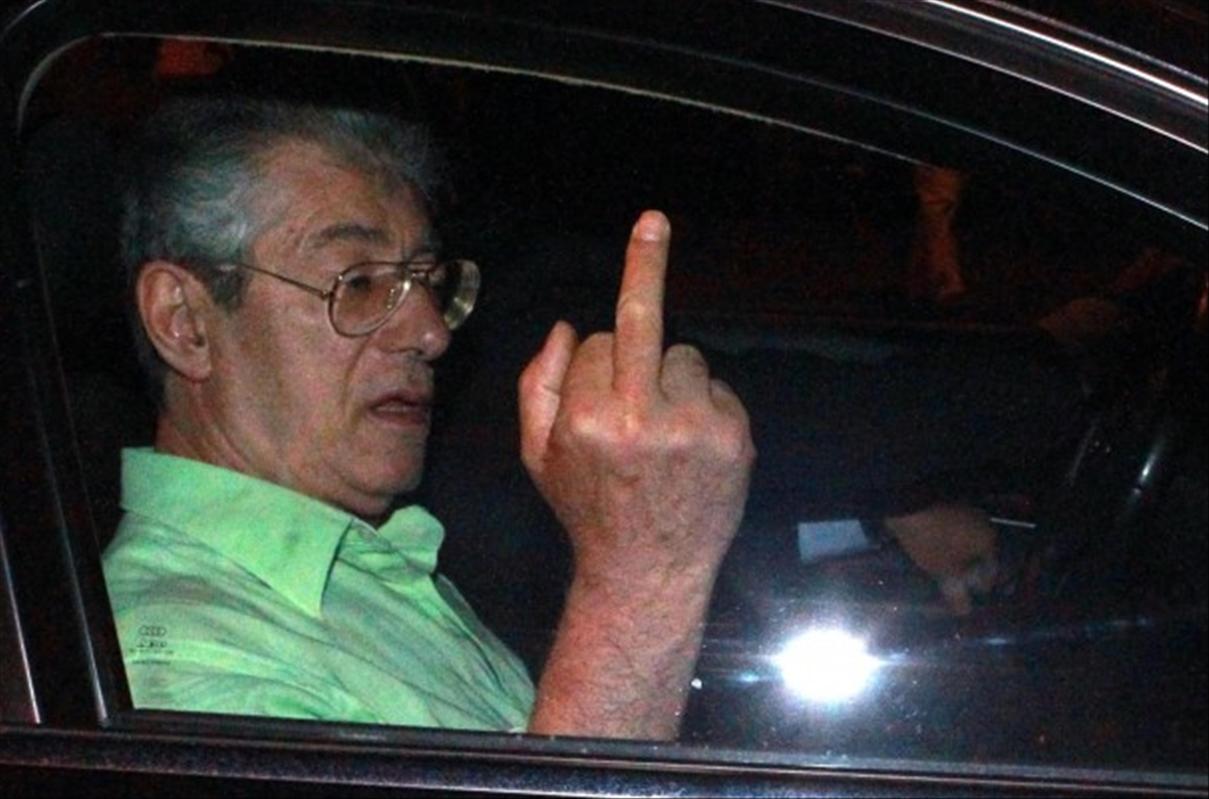Lorenzo Vitelli (L'intellettuale dissidente)
“Ben potrei essere commosso se fossi come voi. Se sapessi pregare per commuovere, le preghiere mi commuoverebbero. Ma io sono costante come la stella del Nord, che per la sua fissità ed immobilità non ha compagna nel firmamento. I cieli sono dipinti con innumerevoli scintille; tutte sono fuoco e ognuna brilla, ma non ve n’è una che tenga il suo posto. Così nel mondo: esso è ben fornito di uomini, e gli uomini sono carne e sangue e dotati di intelletto; eppure tra tutti io non conosco solo uno che, inespugnabile, stia saldo al suo luogo, non scosso da alcuni: e questi sono io” – William Shakespeare, Julius Caesar.
Apparteneva alla famiglia Iulia delle gens originarie, tra le più antiche e nobili di Roma, e si diceva discendente di Venere, dea della bellezza, e di Romolo, fondatore dell’Urbe. Prima Fanciullo dissoluto, seduttore lussurioso, dandy in quella Roma imperiale ricca e potente grazie alle conquiste orientali, poi militare, politico, oratore, condottiero, generale, combattente ardito, esteta della guerra, abile scrittore, dittatore. Ma bastano queste cariche, bastano questi ruoli per dire, davvero, chi fosse Cesare? No. Cesare era Cesare, e l’essere cesari, non basterebbe una vita per descriverlo, non basterebbe un tempo, perché Cesare si protrae, sempre, nella Storia, nell’Imperium, nel buio medioevo, nella commedia del sommo poeta, nei monarchi francesi, nei versi shakespeariani, nei diari di Napoleone, nei cardini dell’Occidente.
Cesare, l’uomo, nasceva il 100 a.C.. Nasceva un nessuno, nipote di Gaio Mario, il Mario rivale di Silla. Dopo una giovinezza dissoluta e la fuga dall’Urbe – per i dissidi con il dittatore – della sua nobiltà non se ne fece niente, e si schierò con il partito dei populares, tendenzialmente opposto agli optimates, nobili e patrizi. Divenne tribuno militare, e dopo la nomina a questore si imbarcò per la Spagna. Tra le terre infuocate della penisola iberica, Cesare non si bastava: “Non vi sembra che ci sia motivo di addolorarsi se alla mia età Alessandro regnava già su tante persone, mentre io non ho fatto ancora nulla di notevole?”. Cesare voleva, doveva diventare Cesare. L’ambizione gli impose di stringere legami con Crasso, il dives, abile politico e speculatore finanziario, che gli stanziò ingenti finanziamenti per l’elezione a pontefice massimo. Divenne console nel 59′, e relazionatosi anche con Pompeo Magno, i tre diedero vita al triumvirato. Cesare scendeva a compromessi, e dopo un anno ottenne, in veste di generale, tre provincie: la Gallia Cisalpina, quella Narbonese e l’Illiria. Esasperata e divina la fase più importante della carriera militare del neo-generale, destinata a renderlo celebre per l’eternità, cominciava a prendere vita.
Retto, clemente, pragmatico, ma anche imprudente, scellerato e ambizioso, animato dall’inestinguibile voglia di dimostrare il suo valore a tutto il popolo romano, alla classe dirigente e, sopratutto, a sé stesso, oltre a domare le provincie affidategli, Cesare espanse il dominio dell’Urbe sino alla Gallia celtica e belgica.
Dopo aver affrontato gli Elvezi e i Germani, capitanati da Ariovisto, poi i Begli e le popolazioni ribelli guidate dal principe suebo Ambiorige, dopo avere calpestato per primo, tra tutti i romani, il freddo suolo britannico ed aver massacrato a Londinium la popolazione barbara che lo aveva attaccato, dopo aver difeso il Reno con tutte le sue forze, sino a mettere a rischio la propria vita tra le prime file delle legioni romane (Plutarco nelle Vite dei Cesari scrive: “Spesse volte le sorti di battaglie ormai perdute erano capovolte grazie all’esempio che Giulio Cesare dava ai suoi.
Si racconta che una volta i nemici stavano per avere la meglio in combattimento. Nella mischia Giulio Cesare, accorgendosi che l’alfiere stava fuggendo, gli si precipitò addosso, lo afferrò per il collo e facendolo voltare indietro gli disse: “Vedi che i nemici sono da quella parte!”, dopo aver fatto chinare ai suoi piedi anche l’ultimo ribelle Gallico, Vercingetorige, Cesare si avvicinava sempre più all’essere Cesare, e si incamminò verso Roma.
Ma essere Cesari vuol dire anche essere odiati, e mentre il Senato gli metteva i bastoni tra le ruote, mentre legiferava in sua assenza contro di lui, ecco che, sulle sponde del Rubicone, si pronunciava l’Alea iact est che mosse 50.000 uomini verso Roma e uno solo verso il suo destino.
A proteggere l’Urbe il Senato aveva delegato Pompeo, l’eroe d’Oriente che aveva placato poco prima la rivolta degli schiavi guidata da Spartaco. Ma il Magno non aveva quella freddezza di spirito e la destrezza bellica che permisero a Cesare di rovinarlo a Farsalo e infine trovarlo morto in Egitto.
Se molti dicono che non basta conquistarsi il potere senza conquistarsi il popolo, Cesare aveva sedotto anche questo, come aveva fatto con la lussuriosa Cleopatra ad Alessandria. Cicerone scriveva su di lui:“Egli ebbe ingegno, equilibrio, memoria, cultura, attività, prontezza, diligenza. In guerra aveva compiuto gesta grandi, anche se fatali per lo stato. Non aveva avuto per molti anni altra ambizione che il potere, e con grandi fatiche e pericoli l’aveva realizzata. La moltitudine ignorante se l’era conquistata coi doni, le costruzioni, le elargizioni di viveri e banchetti. I suoi li aveva acquistati con premi, gli avversari con manifestazioni di clemenza, insomma aveva dato ad una città, ch’era stata libera, l’abitudine di servire, in parte per timore, in parte per rassegnazione.”
Cesare aveva dimostrato a sé stesso e a gli altri la sua grandezza militare e strategica, ma doveva ora dare sfogo all’arte governativa. L’economia politica delle grandi opere, quasi keynesiana, fu il primo passo delle lunghe riforme che cambiarono l’Urbe; passo che gli acconsentì di sfruttare le costruzioni architettoniche – come il Forum Iulium e la grande biblioteca – per offrire nuovo lavoro alla popolazione e, allo stesso tempo, per aumentare la sua popolarità tramite l’influenza propagandistica di questi edifici.
L’assetto amministrativo del Governo intanto cambiava forma, e la possibilità di accesso al Senato venne data ai populares, ai tribuni della plebe e, cosa più sconcertante e innovativa, anche ai galli; il dittatore concesse poi la cittadinanza romana a molti degli abitanti delle provincie. Luciano Canfora, storico italiano, scrive: “Con Cesare Roma diventa tutta l’Italia, compresa la Cisalpina. Roma cioè, in quanto concetto giuridico e politico, si identifica – grazie all’estensione della cittadinanza – con l’intera Italia.”
Ma Cesare, gli rinfacciavano gli ottimati, si stava dimenticando di loro e della Repubblica. Questa dimenticanza era forse dovuta all’interesse per il popolo, e le nuove riforme erano intente a colpire direttamente l’antico monopolio dei patrizi, quella sorta di oligarchia usuraia che prima imponeva la sua dittatura su tutto il territorio romano. Cesare iniziò così con una politica rigorosa, una politica di regolamentazioni sul mercato, sui tassi di interesse e sulle speculazioni edilizie: questo fu interpretato come un attacco profondo verso il Senato: la culla dei privilegi della casta dominante. Fu dato sempre maggior potere alle assemblee popolari a detrimento di questa istituzione corrotta, che si innalzò a 900 senatori, la maggior parte fedeli all’autocrate. L’idea dello Stato ebbe un profondo mutamento nello spirito romano, sino a divenire più uniforme ed omogenea, e sebbene fu meno libertaria, sicuramente sembrava più equa.
Mentre Cesare applica le sue riforme, gli ottimati anticesariani – tra cui Giunio Bruto (pompeiano graziato da Cesare dopo la sconfitta del Magno) e Cassio Longino, per citare i più celebri – tramarono alle sue spalle la congiura che alle idi di Marzo gli causò la morte.
Cesare, in quel periodo, era quasi Cesare, ad un passo dal suo essere compiuto, essere, nella sua totalità, che solo la morte, finalmente, gli avrebbe potuto concedere. Gli storici raccontano che fosse spassionato, depresso, disilluso, dagli occhi persi, spenti, scavati, dai lineamenti tesi. Diceva di aver bisogno di un’altra guerra per uscire da quella condizione abulica, diceva di voler attaccare i Parti: ma dappertutto, nell’aria, in quella Roma alle porte della primavera, si parlava di congiure e tradimenti, e dei presagi, sempre più frequenti, scatenavano sconforto tra i familiari del dittatore e nel popolo. Tutti fiutavano il pericolo, tutti, tranne Cesare.
Qualche giorno prima di entrare nel Senato semivuoto, racconta Plutarco, “un indovino aveva ammonito Giulio Cesare a guardarsi da un grande pericolo che lo aspettava alle idi di marzo. Giunte che furono le idi, mentre si recava in Senato, Cesare incontrò l’indovino e, salutandolo, gli disse scherzosamente:
- Le idi sono giunte! – Si, sono giunte – ribatté l’indovino a bassa voce – ma non sono ancora trascorse!”. Quel 15 Marzo del 44 a.C fu fatale, e quando il dittatore si sedette sul suo scranno dorato, disincantato, abbracciava il suo destino ineluttabile. Publio Casca per primo sferzò una pugnalata, non mortale, sul collo di Cesare, che gridò “Scelleratissimo Casca, che fai?”. I congiurati – tutti senatori repubblicani graziati da Cesare, che gli giurarono fedeltà e protezione a costo della vita – gli si scagliarono contro, senza pietà. “Amo il tradimento ma non il traditore” diceva Cesare.
Prima di accasciarsi esanime, paradossalmente sotto la statua di Pompeo, la vittima si richiamò a Bruto, intento a trafiggerlo, e pronunciò le sue ultime parole: “tu quoque, Brute, fili mi!”. Cesare era morto, era diventato Cesare.
Il cesaricidio, termine che divenne famoso nel tempo, nacque con la volontà dei congiurati di uccidere la tirannia a tutti i costi, e se non vi fossero riusciti tanto valeva togliersi la vita, come aveva fatto Catone, in Utica, non potendo sopportare le catene della dittatura.
Cesare era ritenuto l’assassino della Repubblica e della democrazia, ma oltre gli idealismi degli optimates, che celavano in sé un misto di astio generale e rancore personale, al di là di questa smania di eliminare il tiranno, non si nascondeva forse tutta l’avidità, l’odio e l’egoismo di una classe dirigente che sino a poco prima abusava del suo potere per lucrare sulle spalle dei cittadini? La Repubblica era morta da tempo, e forse non era mai nata, neanche con la morte di Tarquinio il Superbo, l’ultimo re di Roma, che Licinio Bruto aveva abilmente rovesciato. La Repubblica, se mai fosse esistita, venne suicidata, e Cesare fu l’uomo partorito da quel tempo e di cui il suo tempo aveva bisogno per rifondare una nuovo Stato: un uomo forte, ingegnoso, che seppure, possiamo pensare, non abbia dato a Roma e al popolo romano la libertà, ebbe almeno ristabilito l’ordine in quel caos repubblicano che non faceva altro che tramare complotti ed inganni per rendere il ricco ancora più ricco e il forte ancora più forte. Latifondisti agrari, speculatori edilizi, finanzieri liberali, tutti i rappresentanti del Senato erano corrotti e corruttori: Cicerone, Crasso, Pompeo, Cesare lo fu a suo tempo, per favorire la sua ascesa, e lo stesso Catone che Dante, sebbene pagano, colloca nella sua commedia alle porte del purgatorio, per l’alta moralità e incorruttibilità. Questo è ciò che ha portato Cesare alla morte, l’aver tolto alla classe dominante il Senato e il potere che da questo ne traeva.
Ma Cesare fu ben più grande, egli fu il precursore dell’Impero che guidò il mondo per più di tre secoli dopo di lui. Ottaviano Augusto invero, tramite il diritto di successione, dopo il suo conflitto con Marco Antonio, divenne tribuno della plebe, pontefice massimo e imperatore proconsolare a vita. Inutile fu dunque la combutta di Bruto che, assieme a Cassio, si suicidò una volta sconfitto nella seconda battaglia dei Filippi dal giovane erede adottivo del dittatore.
Cesare ha dato vita ad una nuova Roma, meno democratica? meno giusta? Le sue riforme agrarie e sociali furono viste dagli ottimati come un attacco frontale al potere del Senato, ma qual’era l’ottica popolare? Quando il popolo seppe dell’accaduto e vide nel testamento che il tiranno aveva donato ai cittadini dell’Urbe tutti i giardini gianicolensi andò su tutte le furie e linciò i primi congiurati che gli passarono sotto mano. La domanda a questo punto rimane aperta: egli fu un bene o un male per Roma? Ciò che possiamo affermare è che Cesare fu necessario per sanare la crisi di una Repubblica che avrebbe portato ancor prima il popolo romano alla decadenza, al costo, però, di una guerra civile.
Ma se andiamo al di là del bene e del male non possiamo che ammirare un uomo che ha scritto la sua storia e la Storia, un uomo che, con destrezza e abilità, giocò le sue carte e mosse le sue pedine da grande giocatore, con calcolo freddo e perfezionista da un lato, e con intuito e azzardo dall’altro. Egli fu e continuerà ad essere, per sempre, l’emblema della volontà e della grandezza, e per quanto le parole dei suoi contemporanei e degli storici possano macchiare di atti corrotti e gesta infami la sua vita, Cesare resta un’idea di uomo, di un uomo grande, fuori dal comune, incontenibile, insaziabile, divino.